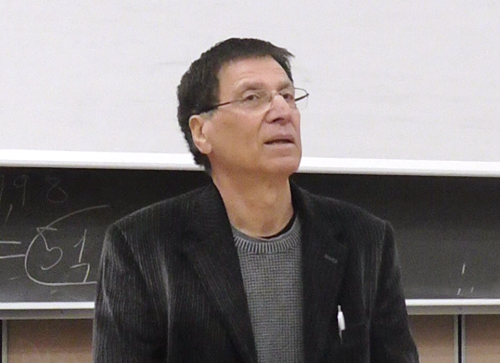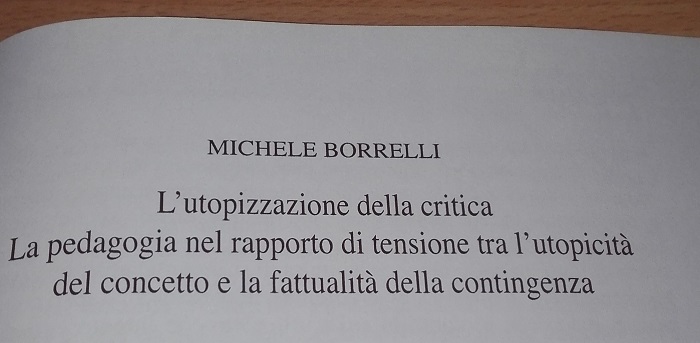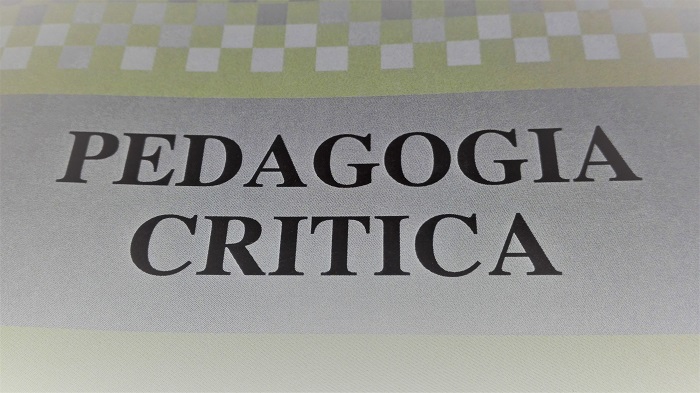|
|
|
La pedagogia critica o la critica in pedagogia
nel pensiero di Michele Borrelli
La critica non è necessariamente, o di per sé, uno
strumento di conoscenza e verità, piuttosto solo un mezzo ipotetico
di pensiero e di ricerca, che rivela un doppio carattere e che può
essere usato, quindi, sia in senso dogmatico sia in senso utopico.
Come dogmatica, la critica è sempre legata a una determinata
posizione; come utopia, la critica si oppone a ogni
sostanzializzazione. Ciò rinvia a una paradossalità alla quale non
possono sottrarsi neppure l’educazione e la formazione: al
dogmatismo inaggirabile di una critica legata a una determinata
posizione, educazione e formazione contrappongono la
non-definitività e apertura del pensare e dell’agire umani. Al
centro del pedagogico è da porsi non la dogmatizzazione ma
l’utopizzazione della critica. Quest’ultima cerca di proteggere la
critica da ogni assolutizzazione e privatizzazione e di difenderla,
tra l’altro, anche contro se stessa.
La criticità del
pedagogico si rapporta, non da ultimo, al concetto stesso di
pedagogia, ossia alla possibilità e necessità di una sua proiezione
nel futuro indefinibile e utopico. Pertanto, il concetto di critica
sottostà alla legge di ciò che esso stesso critica. La critica non
esclude, quindi, interpretazioni contrarie e rimane tale nella sua
funzione, fino a quando non sostanzializza il senso storico; in
questo caso, però, subentra al criticato sostituendolo solo
dogmaticamente con un altro senso. Vale lo stesso per miti come la
società, l’umanità, la libertà, l’autonomia, il soggetto,
l’educazione, l’autoeducazione, la formazione e simili. La loro
forza è sorretta dalla concettualizzazione controfattuale. Nel
momento in cui sono ridotti a essenze storico-sostanziali, non sono
più concetti aperti, ma solo dogmi, anche se possono avere contenuti
diversi, forse anche contrari e contraddittori rispetto ad altri.
Come critica sostanzializzata essa non è mai formale, ma sempre
retta da contenuti. Essa è, sempre e al tempo stesso, di posizione,
cioè legata a determinate premesse e, come tale, non può fare a meno
di una determinata dogmatica di partenza.
Senza la
paradossalità secondo cui la critica è rivolta sempre contro le
sostanzializzazioni del contingente e che, tuttavia, essa stessa non
può fare a meno di ogni sostanzializzazione contingente per essere
tale (col che dovrebbe autointendersi come ricerca continua di
lavoro al concetto), la critica sarebbe senza alcun senso. Il senso
della critica in pedagogia è legato, dunque, alla consapevolezza del
riconoscere che essa non è senza premesse. La penetrazione di questa
struttura che precede la critica apre lo sguardo al fatto che la
critica si pone al contempo e sempre in ottica critica e non
critica.
Lo stesso credere
alla possibilità di un pensiero libero da ogni metafisica e da ogni
posizione non avrebbe possibilità di articolazione senza una
dogmatica di partenza, ma sarebbe altamente sospetta nel suo
antidogmatismo di seguire dogmi senza farli oggetto di riflessione
(cfr. Adorno: Wozu noch
Philosophie?). L’ammissione di un resto inaggirabile di
dogmatica, senza il quale la critica non sarebbe possibile, è ricco
di conseguenze per il chiarimento di ciò che bisogna intendere con
critica in pedagogia e pedagogia critica. Fa parte dell’autoevidenza
di quest’ultima che la critica non solo non è possibile senza nessun
resto di dogmatica, ma che essa senza questo resto sarebbe anche
senza senso; che le dogmatiche, invece di escludere a loro volta la
critica per definitionem, non devono necessariamente essere
insensate, piuttosto possono provocare nuove forme di critica e,
mediate attraverso queste, favorire il sorgere di nuove utopie.
Il rapporto tra fattualità (contingenza) e
concetto (utopia) in pedagogia
Come passato e
presente dimostrano, la pedagogia si può concepire sia in senso
critico, scettico, rivoluzionario, ma anche in senso affermativo o,
addirittura, reazionario. A volte essa conferma la sua contingenza
storica, definendosi tautologicamente in rinvio alla consuetudine, a
istituzioni determinate, alla logica di uno specifico dominio
politico; a volte si pone in contraddizione alle forme di
socializzazione che l’accompagnano pragmaticamente nella contigenza
degli ordinamenti e delle norme sociali. In base alla dimensione
dell’utopicità che co-costituisce il concetto, la pedagogia si
contrappone a ogni sua riduzione empirica e contingente.
Paradossalmente, l’altra dimensione del concetto: la contingenza,
esige che, senza riduzioni sul piano storico-pragmatico, la
pedagogia non ha possibilità di sopravvivenza. Questo è il motivo
fondamentale in base al quale in pedagogia sono presenti, al tempo
stesso e con analogo grado di legittimità e di pretesa fondazionale
o critica, l’una accanto all’altra, strutture antinomiche e dispute
senza limiti.
Alcune di queste
antinomie strutturali:
-
Obbligata all’autonomia e
all’emancipazione dell’individuo, appartiene ai compiti della
pedagogia (come proposta educazionale) sottrarre l’individuo
all’(auto)eteronomia che – il paradosso vuole – la stessa pedagogia
de facto in lui produce e riproduce attraverso un determinato
modello di contingenza o di socializzazione. Ciò preannuncia già la
prima dimensione del contrasto inaggirabile tra utopia e fattualità
o contingenza;
-
Orientata alla totalità della società e
non solo all’individuo, deve preparare i singoli a formare se stessi
(autonomia e partecipazione sono termini abituali del lessico
pedagogico) e non ad essere formati. In ciò consiste la seconda
dimensione inaggirabile del contrasto tra utopia e contingenza.
-
Obbligata al postulato della libertà
(dell’individuo), la pedagogia deve liberare il singolo dalla sua
libertà eteronomamente normizzata. Si nota qui una terza dimensione
inaggirabile del contrasto tra utopia e contingenza.
Da angolazione
pedagogica, libertà è il liberarsi dell’uomo a se stesso.
L’utopicità del concetto è in contraddizione con la sua
costitutività sociale e fattualità contingente. Appartiene alla
paradossalità della libertà, che il suo concetto e la sua realtà
sono come linee parallele, talché esso è mediabile solo in
prospettiva utopica. Solo in quest’ottica la conciliazione delle due
linee parallele è legittima o almeno pensabile. Il senso della
libertà, rimane, a ben vedere, sempre utopico; non diventa mai
realtà. Ma questo senso utopico non è, però, affatto senza senso.
Non a caso, pedagogicamente, si mostra libero chi è a conoscenza
dell’illibertà del liberare e cerca di liberarsi anche di essa. Vale
altrettanto per tutti gli altri concetti di connotazione e
interpretazione pedagogiche. Tre esempi valgano a dimostrarlo:
-
Umanizzazione è un concetto antinomico. Essere sottomessi a
essa non è umano ed è in contraddizione con la libertà. Quale
pretesa utopica, l’idea di umanizzazione si pone come obiettivo di
liberare a se stessi una dignità che non ha bisogno di costrizione
perché non imposta eteronomamente. Come tale si contrappone
all’umanizzazione come costrizione nel senso proposto da Kant.
Nell’umanizzazione in senso utopico, l’uomo è soggetto e non oggetto
dell’educazione. Appartiene alla paradossalità dell’umanizzazione,
cercare in essa quello che non c’è: l’autoumanizzazione dell’uomo.
-
Autoeducazione. Procede in ogni singolo in modo antinomico.
Il singolo dovrebbe educare il suo Sé che ha bisogno di educazione
per essere tale, ma se il Sé ha bisogno di educazione entra in gioco
l’eteronomia, ossia l’antinomia di Sé e l’altro da Sé; in tale
processo, l’educazione risulterebbe dispensata e, al tempo stesso,
indispensabile. Com’è facile notare l’educazione,
nell’interpretazione pedagogica di autoeducazione, risulta
altrettanto paradossale e utopica come i concetti di umanizzazione e
libertà.
-
Un’ulteriore paradossalità si riscontra
nel concetto di società. L’educazione si avvera nella
società; educa attraverso questa e non contro di essa. Però, una
società che educa non ha bisogno di educatori. Ma come osserva Marx,
la società è educata a educare? Considerata in prospettiva sociale,
ogni educazione è socializzazione contingente, ossia tautologia
per definitionem. L’educazione critica, aveva inteso se
stessa, non a caso, come quell’istanza di riflessione che porta alla
conoscenza dell’educando le condizioni e le determinanti di
socializzazione e acculturazione, prima ancora che egli abbia la
possibilità di rendersene conto. Questa consapevolezza procede in un
regresso infinito. Appartiene all’educazione permanente non solo il
continuo ripensarsi in termini di futuro, ma anche, e soprattutto,
il rientrare dell’autocoscienza nelle condizioni contraddittorie e
paradossali del suo esser-se-stessa. Nell’autocoscienza ritrovata e
ripensata il soggetto risoggettiva utopicamente la sua riduzione
contingente a oggetto di educazione attraverso l’educazione. La
coscienza sperimenta la sua eteronomia, ma non si porta oltre
questa.
Come autoeducazione utopica (per sé un paradosso),
l’educazione premette il suo opposto: l’antinomia, il liberarsi,
cioè, dalla prigionia della socializzazione cui né la società né il
singolo soggetto sono capaci. Il soggetto dell’educazione rimane,
allora, la società. Ne consegue un ulteriore paradosso. La società
oggettiva il soggetto e diventa essa stessa un soggetto
oggettivato che, come tale, corrisponde all’oggettivazione
dell’individuo che oggettivamente è diventato la sua vittima (cfr.
Adorno:
Negative Dialektik, Jargon der Eigentlichkeit). Società, soggetto e individuo si mostrano
concettualmente una necessità utopica, sul piano della contingenza
storica sono, però, tautologie.
Estratti dal saggio di Michele Borrelli,
«L’utopizzazione della critica. La pedagogia nel rapporto di
tensione tra l’utopicità del concetto e la fattualità della
contingenza», in Idem (a cura di/ed.),
Pedagogia critica,
Pellegrini, Cosenza 2004, pp. 211-232; anche in versione
tedesca/also in german version: «Utopisierung von Kritik. Pädagogik
im Spannungsverhältnis von utopischem Begriff und kontingenter
Faktizität», in D. Benner, M. Borrelli, F. Heyting e C. Winch
(hrsg./ed.),
Kritik in der Pädagogik. Versuche
über das Kritische in Erziehung und Erziehungswissenschaft,
‘Zeitschrift für Pädagogik’, n.46, Weinheim: Beltz 2003, pp.
142-154; e in versione inglese/ also available in english: «The
Utopianisation of Critique: the Tension between Education Conceived
as a Utopian Concept and as one Grounded in Empirical Reality», in
F. Heyting, C. Winch (edited by),
Conformism and Critique in
Liberal Society, ‘Journal of Philosophy of Education’, Vol. 38,
Issue 3, Oxford: Blackwell Publishing Incorporated. 2005, pp.
441-454.
|